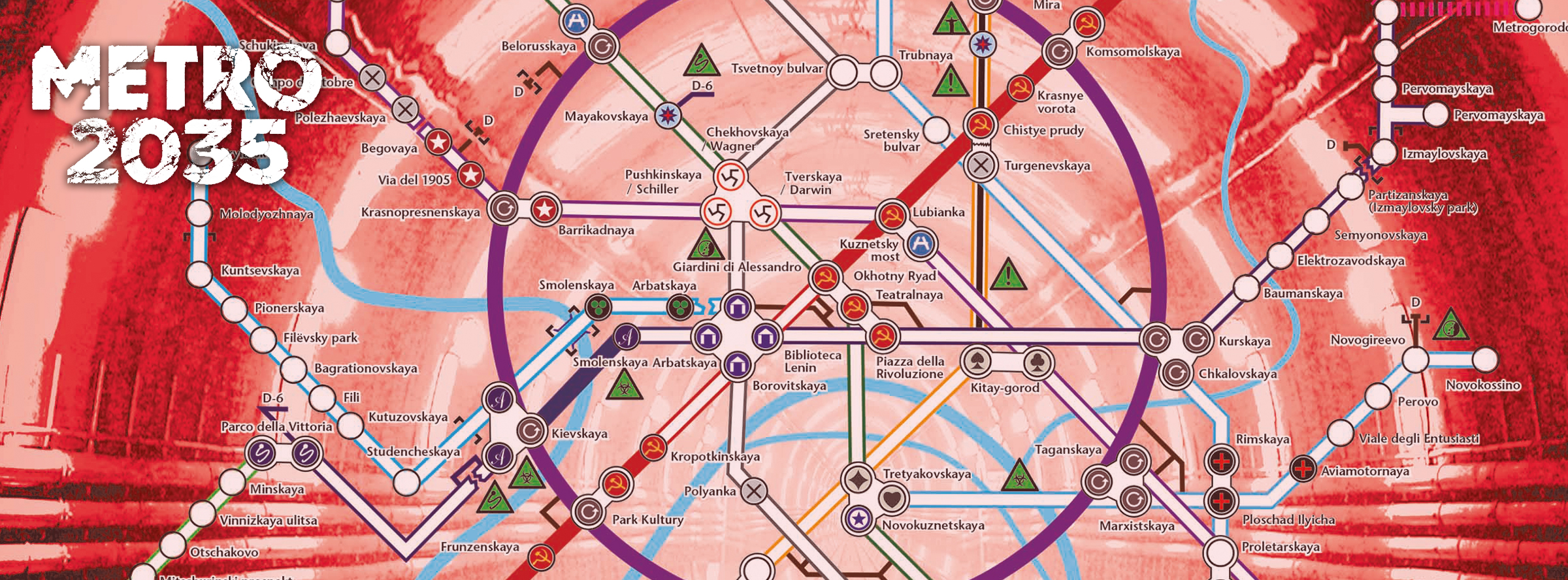Metro 2035: Artyom torna in superficie…
Tutti voi sapete che Metro 2033 ha creato un universo. Non sappiamo se tutti sapete che i libri 2033, 2034 sono pubblicati anche online, sul sito italiano METRO2033UNIVERSE.IT
Per non perdere il filo, per capire cosa c’è stato prima, per introdurvi al mondo di Glukhovsky, vi consigliamo vivamente di “frequentare” quelle pagine, non ve ve pentirete.
Se vi siete persi le news precedenti, forse vi siete dimenticati che siamo al terzo estratto del libro.
Questa è la prima anteprima :
METRO 2035 O LA REALPOLITIKE DI DMITRY GLUKHOVSKY – ANTEPRIMA
Poi potrete proseguire fino al secondo capitolo compreso, a questo LINK
Ora potete procedere qui …
Capitolo Due
LA METROPOLITANA
“Ma tu almeno cerchi di ascoltarmi?”, chiese ad Anya.
Lei però non c’era già più nella tenda.
I suoi vestiti erano esattamente dove li aveva buttati:
nel passaggio. Anya non li aveva messi in ordine, non li aveva raccolti. Ci era passata sopra come se avesse paura di toccarli. Di contaminarsi. Forse ne aveva sul serio.
Probabilmente la coperta a lei serviva di più. Lui trovava sempre il modo di scaldarsi.
Meno male che se n’era andata. Grazie, Anya, di non aver parlato con me, di non avermi risposto.
“Grazie, cazzo!”, esclamò a voce alta.
“Permesso?”, disse qualcuno attraverso il telone, proprio sopra il suo orecchio. “Artyom, non dorme?”
Artyom si allungò per prendere i suoi pantaloni.
Là fuori, seduto su uno sgabello pieghevole da campo, lo aspettava un vecchio dal viso troppo dolce per la sua età. Se ne stava seduto bello comodo, in equilibro, ed era chiaro che si era sistemato lì da un po’ e non aveva alcuna intenzione di andarsene. Il vecchio era forestiero, non della loro stazione: faceva delle smorfie, aveva imprudentemente inspirato col naso. I forestieri si riconoscevano subito.
Con le mani Artyom si riparò dalla luce rossa che inondava la stazione VDNKh ed esaminò l’ospite.
“Che ti serve, vecchio?”
“Lei è Artyom?”
“Diciamo di sì”, Artyom inspirò l’aria col naso. “Dipende”. “Io sono Omero”, dichiarò il vecchio senza alzarsi.
“Mi chiamo così”.
“Davvero?”
“Io scrivo libri. Anzi, un libro”.
“Interessante”, rispose Artyom con una voce che esprimeva
l’esatto contrario.
“Un libro storico, diciamo così… ma che riguarda i nostri
giorni”.
“Storico”, ripeté Artyom con prudenza mentre si guardava
intorno. “A che scopo? Dicono che la storia non ci sia più! Finita!” “E noi? Qualcuno dovrà pur raccontare ai posteri tutto
quello che ci sta succedendo qui”.
Se non veniva da parte di Melnik, pensava Artyom, chi era? Da chi era mandato? A che scopo?
“Ai posteri. È una cosa sacra”.
“Da una parte bisogna raccontare quello che è più importante, cioè come viviamo qui. Bisogna raffigurare tutte le tappe, le peripezie, diciamo. D’altra parte, come si fa? Gli aridi fatti si dimenticano. Se si vuole che le persone si ricordino, serve una storia vera, un protagonista. Io ho cercato del materiale, ho provato di tutto. Credevo di averlo trovato. Ma quando mi ci sono messo… non ha funzionato. E poi ho sentito della VDNKh e…”
Si vedeva che il vecchio faceva fatica a spiegarsi, ma Artyom non aveva intenzione di aiutarlo. Non riusciva a capire cosa sarebbe successo. Dal vecchio non veniva energia negativa, si capiva solo che era fuori posto, eppure tra lui e Artyom si stava coagulando qualcosa nell’aria, si stava formando qualcosa pronto a esplodere, a bruciare e a spargere frantumi.
“Mi hanno raccontato della VDNKh… dei Tetri… e di lei. E ho capito che dovevo trovarla per…”
Artyom annuì: era finalmente arrivato al punto. “Un’ottima storia”.
E si allontanò senza salutarlo, con le mani perennemente
gelate infilate nelle tasche.
Il vecchietto rimase lì sul suo comodo sgabello, continuando
a spiegare qualcosa alla schiena di Artyom. Ma lui aveva deciso: era diventato sordo.
Sbatté le palpebre – gli occhi si erano ormai abituati, poteva non strizzarli più.
Avevano impiegato più tempo per familiarizzare col mondo in superficie. Un anno, se non di più! La maggioranza degli abitanti della metropolitana, se esposti alla luce del sole, seppur sfocata dalle nubi come quella odierna, sarebbe probabilmente diventata cieca per sempre. Dopo una vita al buio. Artyom invece si era forzato a guardare in superficie, a vedere il mondo nel quale era nato. Perché se non sopporti il sole, come potrai un giorno risalire?
Tutti quelli nati nella metropolitana erano cresciuti senza sole, come i funghi. Nessun problema: si era scoperto che agli uomini serviva la vitamina D, non il sole. Si poteva mangiare la luce solare sotto forma di compresse. Si poteva vivere anche a tastoni.
Nella metropolitana non c’era illuminazione né elettricità in comune. Non c’era niente in comune, in realtà: ognuno pensava per sé. In alcune stazioni si erano ingegnati a produrre abbastanza luce perché fosse quasi come prima. In altre, l’elettricità era sufficiente per una sola lampadina che ardeva in mezzo alla banchina. In altre stazioni ancora era buio come nelle gallerie. Se si andava lì con una torcia in tasca, si riusciva a guadagnare terreno sulle tenebre: il pavimento, il soffitto, una colonna di marmo. Alla luce della sua lanterna si affacciavano gli abitanti della stazione, desiderosi di vedere un po’. Ma avrebbero fatto meglio a non mostrarsi: si erano abituati perfettamente a vivere senza occhi, ma le loro bocche non si erano cicatrizzate.
Nella stazione VDNKh la vita era ben organizzata e la gente era viziata. Nelle tende di alcuni ardevano dei piccoli diodi portati giù dalla superficie e nelle zone comuni c’era la vecchia illuminazione, sopravvissuta ai guasti: delle lampade dentro paralumi rossi di vetro, una luce ideale per sviluppare le fotografie, per esempio. Anche l’anima di Artyom con questa luce si manifestava lentamente e si vedeva che era stata ripresa ancora lassù, in una chiara giornata di maggio. Mentre in un cupa giornata di ottobre era stata bruciata.
“Una storia meravigliosa, non è vero, Zhenya? Ricordi i Tetri?”, sussurrava Artyom, ma rispondevano sempre gli altri. Rispondevano sempre quelli sbagliati.
“Salve, Artyom!”
“Oh, Artyom!”
Tutti si salutavano. Qualcuno sorrideva, qualcun altro
aveva un’aria accigliata, ma si salutavano, tutti. Perché tutti si ricordavano dei Tetri, e non solo Zhenya e Artyom. Tutti ricordavano quella storia, anche se nessuno la conosceva.
Stazione della metropolitana VDNKh: ultima fermata. Casa sua. Lunga duecento metri e abitata da duecento persone. Lo spazio era quello giusto: di più non sarebbero riusciti a respirare, di meno non si sarebbero scaldati a vicenda.
La stazione era stata costruita cento anni prima, ai tempi del precedente Impero, coi tipici materiali di quel periodo: marmo e granito. Era stata concepita come un palazzo solenne, ma scavata sottoterra; il risultato era una via di mezzo tra un museo e un mausoleo. Lo spirito degli avi era lì, come del resto anche nelle altre stazioni, perfino in quelle più recenti, assolutamente incrollabile. Gli abitanti della metropolitana erano aumentati, eppure continuavano a stare seduti sulle ginocchia bronzee degli antichi vegliardi, e non c’era modo di scendere – non li mollavano. Sotto le arcate, fra solenni colonne annerite dal fumo, erano state sistemate vecchie e consunte tende militari: in ognuna viveva una famiglia, in alcune due. Mescolando a caso questi nuclei, nessuno avrebbe probabilmente notato la differenza: ciò accade quando si vive insieme da vent’anni nella stessa stazione, quando tra i tuoi segreti e quelli dei tuoi vicini, tra tutti i lamenti e le urla, c’è solo un pezzo di tela.
Da qualche altra parte le persone si sarebbero già mangiate a vicenda – per l’invidia, la rabbia verso Dio che ama di più i figli degli altri, per l’incapacità di condividere il proprio marito o la propria moglie; la sola superficie abitativa sarebbe stata ragione sufficiente per ammazzare, ma non lì, non alla VDNKh. Lì si era creata una grande famiglia.
Come in campagna o in una comune. Non c’erano bambini altrui: se ai vicini nasceva un bimbo sano tutti facevano festa, se te ne nasceva uno malato ti aiutavano ad andare avanti, ognuno come poteva. Non c’era lo spazio per spostarsi, anche gli altri si sarebbero mossi. Se litigavi con un amico la mancanza di spazio vi obbligava a far pace. Se tua moglie se ne andava, prima o poi la perdonavi. In realtà non era andata da nessuna parte, era rimasta lì, in quella sala di marmo sulla quale gravava un milione di tonnellate di terra, al massimo dormiva dietro un altro pezzo di tela. Vi incontrereste ogni giorno, e non una volta, ma cento. Vi toccherebbe trovare un accordo. Non riusciresti a pensare a come vivere senza di lei.
La cosa fondamentale era essere tutti vivi, per il resto… Come in una comune o in una grotta.
Da lì partiva il tunnel meridionale che portava alla stazione Alekseevskaya e oltre, verso la grande metropolitana, ma… Ma il punto era proprio che la stazione VDNKh era l’ultima. Viveva lì chi non voleva e non poteva più andare da nessun’altra parte, chi aveva bisogno di una casa.
Artyom si fermò vicino a una tenda, si bloccò. Rimase lì illuminando con la sua torcia l’interno del giaciglio attraverso la tela lisa, finché non uscì una donnetta col viso gonfio.
“Salve, Artyom”.
“Buongiorno, Katerina Sergeevna”.
“Zhenya non c’è, Artyom”.
Lui annuì. Gli venne voglia di accarezzarle i capelli,
di prenderla per mano, di dirle: “Sì, lo so. So tutto, Katerina Sergeevna. O lo racconta a se stessa?”
“Vai, Artyom, vai. Non stare qui in piedi. Vai là, beviti una tazza di tè”.
“Sì, sì”.
Il salone della stazione era tagliato all’altezza delle scale mobili da un’estremità all’altra – si erano murati dentro in modo che l’aria avvelenata non filtrasse dall’esterno… e per difendersi da ospiti indesiderati. Da una parte, dove c’era la nuova uscita, era murato completamente. Dall’altra, presso la vecchia, era stata lasciata un’apertura per salire in città.
Accanto al muro cieco si trovava la cucina. Ai fornelli le donne col grembiule erano tutte affaccendate a mettere insieme il pranzo per figli e mariti; l’acqua scorreva attraverso i filtri a carbone, gorgogliava fluendo nei serbatoi, quasi trasparente; ogni tanto il bollitore iniziava a fischiare – dalla fattoria avevano mandato uno a prendere l’acqua bollente, e costui si strofinava le mani contro i pantaloni, cercava tra le cuoche sua moglie per toccarle il sedere, ricordarle il suo amore e, già che c’era, scroccare qualcosa di quasi pronto da mangiare.
I fornelli, i bollitori, le stoviglie, le sedie e i tavoli – tutto apparteneva al kolkhoz, ma le persone trattavano le cose con cura, non le rovinavano.
Tutto, a parte il cibo, veniva portato dall’alto; nella metropolitana non si riusciva a fare nulla di decente. Per fortuna i morti, quando ancora pensavano di vivere, avevano messo da parte un sacco di cose utili: lampadine, generatori diesel, cavi, armi, pallottole, stoviglie, mobili; avevano cucito mucchi di vestiti. Adesso si potevano indossare, come si fa con le cose dei fratelli o delle sorelle maggiori. Sarebbero bastati per lungo tempo, in tutta la metropolitana c’erano circa quarantamila persone – a Mosca prima vivevano quindici milioni di abitanti, tutti avevano trecento parenti. Si radunavano senza fare rumore, allungavano in silenzio i loro vestiti smessi: prendili, prendili, sono quasi nuovi, a me stanno piccoli.
Bisognava solo controllare le cose col dosimetro, per essere sicuri che non fossero troppo contaminate, ringraziare e utilizzarle.
Artyom arrivò fino alla coda del tè e si mise in fila.
“Artyom, ma dove vai? Come se non fossi uno di noi… E si mette anche in fila! Siediti ai piedi della verità… Ti verso qualcosa di caldo?”
Lì comandava Dasha, detta anche Pelliccia, una donna sulla cinquantina che non voleva affatto pensare alla sua età. Era arrivata a Mosca da un qualche paesino sperduto nei pressi di Yaroslav tre giorni prima che tutto crollasse. Per comprarsi una pelliccia. E l’aveva acquistata. Da allora non se l’era più tolta, né di giorno né di notte, neanche per andare al gabinetto. Artyom non rideva mai di lei, magari fosse rimasto anche a lui un pezzo della sua vita precedente! Un pezzo di maggio o di gelato, l’ombra dei pioppi o il sorriso della mamma…
“Sì, grazie, zia Dasha”.
“Cosa continui a chiamarmi zia?”, disse con aria di rimprovero, ma anche con una certa civetteria. “Beh, cosa succede lassù? Com’è il tempo?”
“Pioviggina”.
“Non è che finiamo di nuovo allagati? Senti, Aygul? Dicono che piove”.
“È Allah che ci castiga per i nostri peccati. Guarda, ti si starà mica bruciando il maiale?”
“Tiri sempre in ballo il tuo Allah! Sempre Allah! Ma è vero, si sta bruciando… Come sta il tuo Mekhmet? È tornato dall’Hansa?”
“Sono tre giorni che non c’è! Tre!”
“Non essere così in pensiero…”
“Dasha, te lo giuro su ciò che mi è più caro, si è trovato
un’altra! Una delle vostre! Vive nel peccato…”
“Vostre, vostre… cosa dici? Qui siamo tutti uguali,
Aygulka… andiamo tutti d’accordo”.
“Si è trovato una che gliela dà, per Allah…”
“Anche tu avresti potuto dargliela più spesso… Gli uomini
sono come gattini, girano finché non trovano…”
“Ma cosa state dicendo? È in giro per affari!”, intervenne un ometto alto quanto un bambino, con un viso quasi infantile, ma molto più emaciato; per qualche motivo non
era cresciuto normalmente.
“Va bene, va bene. Tu, Kolya, non coprire i tuoi
amichetti! E tu, Artyom, non ascoltare noi donne. Forza, soffia, è bollente”.
“Grazie”.
Si avvicinò un uomo tutto coperto di vecchie cicatrici bianche e completamente calvo, che tuttavia non faceva paura grazie alle sopracciglia folte e al tono evasivo. “Saluto tutti i presenti, le signore a parte! Chi è in fila per il tè? Io allora sono dopo Kolya. Avete già sentito dell’Hansa?”
“Cos’è successo all’Hansa?”
“Il confine è chiuso. Come ha detto qualcuno, si è accesa la luce rossa, non si passa. Cinque dei nostri sono bloccati là”.
“Aygulka, mescola i tuoi funghi”.
“E il mio uomo è lì! E io…! Per Allah… come l’hanno chiuso, Konstantin?”
“L’hanno chiuso e basta. Non è affar nostro. Un ordine è un ordine”.
“Combatteranno di nuovo! Combatteranno di nuovo con la linea Rossa, eh? Magari fossero già crepati tutti! E chi lo sa, Konstantin? Da chi devo andare io? Il mio Mekhmet…”
“Lo fanno per profilassi. Io vengo da lì, è una quarantena per il commercio. Apriranno presto. Buongiorno”.
“Oh buongiorno, buonuomo. È venuto a trovarci? Da dove arriva?”
“Dalla stazione Sevastopolskaya. Mi posso sedere qui?”
Artyom smise di inspirare il vapore bollente e si staccò dalla tazza bianca col bordino dorato scheggiato. Il vecchio era arrivato arrancando fino a lì, lo aveva trovato e ora lo stava studiando di sottecchi, con la coda dell’occhio. Pazienza. Non poteva scappare.
“Ma tu, nonnino, come hai fatto ad arrivare se hanno chiuso tutto?”, Artyom costrinse il vecchio misterioso a guardalo negli occhi.
“Mi sono intrufolato per ultimo”, quello non batteva ciglio, non eludeva la domanda. “Subito dopo me, hanno chiuso”.
“Noi vivremmo anche senza di loro, senza l’Hansa! Ma che provino invece loro, quei parassiti, a vivere senza il nostro tè, senza i nostri funghi! Noi ce la caveremmo, con l’aiuto di Dio!”
“Apriranno… E se non lo facessero? Il mio Mekhmet?”
“Aygulka, vai da Sukhoi. Lui il tuo Mekhmet te lo trova in quattro e quattr’otto. Non ti abbandona. Vuoi un po’ di tè? Hai già provato il nostro?”
“Non lo rifiuto”, il sedicente Omero scosse la barba con dignità.
Sedeva di fronte ad Artyom, sorseggiava il loro decotto di funghi chiamato con orgoglio, ma in modo infondato, tè – quello vero era già stato bevuto tutto una decina di anni prima – e aspettava. Anche Artyom attendeva.
“Chi va a prendere l’acqua bollente?”
Artyom ebbe una fitta al cuore: si era avvicinata Anya. Gli dava le spalle e non lo aveva notato.
“Anyuta, oggi lavori?”, le si rivolse subito Pelliccia, strofinando le mani contro le tasche di pelo consunto. “Funghi?”
“Funghi”, rispose quella sempre di spalle per non voltarsi; aveva visto tutto.
“Ti faranno male le reni a furia di stare sempre chinata”. “Mi si spezzano, zia Dasha”.
“I funghi non sono mica come i porci!”, disse la strabica
e grossa Aygul con un verso di disapprovazione. “Chinata, lei… Prova un po’ a stare nella merda!”
“Stacci tu nella merda. Ognuno si sceglie il lavoro che gli piace”, ribatté fermamente Anya.
La sua replica fu calma, ma Artyom sapeva che proprio quando parlava con quel tono pacato era capace di colpire. Era pronta a tutto, era addestrata. Col padre che si ritrovava…
“Non litigate, ragazze”, borbottò Konstantin col viso a strisce. “Tutte le professioni sono necessarie, tutti i lavori sono importanti, come ha scritto qualcuno più saggio di noi. Senza funghi, come si potrebbe dar da mangiare ai maiali?”
I funghi champignon crescevano nel tunnel settentrionale crollato, uno dei due che prima conducevano alla stazione Orto botanico. Trecento metri di piantagioni di funghi e più in là l’allevamento di suini. I maiali li avevano piazzati più lontano perché ci fosse meno puzza. Come se bastassero trecento metri a salvare dal tanfo. La salvezza era un’altra: il funzionamento dei sensi umani.
I nuovi arrivati percepivano l’abominevole odore di maiale per un giorno o due. Poi si abituavano. Anya non si era abituata subito. Gli abitanti del posto da tempo non sentivano più nulla. Loro non avevano neanche un termine di confronto, mentre Artyom sì.
“È un bene quando i funghi piacciono”, disse scandendo le parole e fissando la nuca di Anya. “È più facile andare d’accordo coi funghi che con le persone”.
“È stupido che certi parlino dei funghi con tanto disprezzo”, replicò lei. “Ci sono persone che non è facile distinguere dai funghi, hanno persino le stesse malattie”. Anya finalmente si girò verso di lui. “Ecco, oggi per esempio su metà dei miei funghi c’è della muffa. È comparsa la muffa, capisci? Da dove è spuntata?”
“Che tipo di muffa?”, si preoccupò Aygul. “Ci manca solo la muffa. Che Allah ci salvi!”
“Chi vuole del tè?”, si intromise Pelliccia.
“Ho raccolto una cassetta di marciume”, disse Anya guardando Artyom negli occhi, “ma prima erano dei funghi normali, sani”.
“Questa è proprio una sventura!”, scosse la testa Artyom. “I funghi sono andati a male”.
“Che mangeremo allora?”, osservò Pelliccia ragionevolmente.
“E sarebbe questa una sventura?”, gli rispose Anya con voce bassa e metallica. “Una vera disgrazia è quando nessuno prende più sul serio il grande eroe e salvatore di tutta la metropolitana!”
“Andiamo, Aygul, prendiamo un po’ d’aria”, Pelliccia sollevò il sopracciglio disegnato. “Qui fa piuttosto caldo”.
“Ehmmm…”, Omero si alzò dietro agli altri.
“No”, lo fermò Artyom, “tu non volevi ascoltare la storia dell’eroe? Di Artyom che ha salvato tutta la metropolitana? Ecco, ascolta, ascolta tutta la verità. Pensi che alla gente importi?”
“Il fatto è che le persone hanno da fare. Devono lavorare, dare da mangiare alla famiglia, far crescere i figli. La vera disgrazia è quando qualcuno si tormenta perché non riesce a trovare un’occupazione e si inventa cazzate di tutti i tipi”, Anya si era schierata e sparava contro di lui raffiche di varia durata: breve, breve, lunga.
“No, la sciagura è quando un uomo non vuole vivere come un uomo, ma come un maiale e come un fungo”, rispose Artyom. “Quando lo preoccupa una sola cosa…”
“La sciagura è quando un fungo decide di essere un uomo”, ribatté Anya senza più celare l’odio, “e nessuno gli dice la verità per non rattristarlo”.
“È vero che sui funghi c’è della muffa?”, chiese Dasha, che stava quasi per andarsene.
“È vero”.
“Maledizione!”
“È Allah che ci castiga!”, esclamò Aygul con voce tonante
da un certa distanza. “Per i peccati! Per il fatto che mangiamo carne di maiale!”
“Vai… vai… i funghi ti chiamano…”, Artyom spinse Anya che si era bloccata. “Tossiscono, starnutiscono. Dicono dove sei, mamma?”
“Sei un bastardo. Un inutile bastardo”. “Vai”.
“Mi aspetto più dai funghi che da te”. “Su, vai!”
“Vai tu, piuttosto! Ritorna su! Sistema l’antenna della città!
Squarciati la gola coi tuoi piagnistei. Lì non c’è nessuno, hai capito? Nessuno. Sono tutti crepati. Radioamatore. Coglione”.
“Tu stessa poi…”
“Non ci sarà nessun poi, Artyom. Non ci sarà”.
I suoi occhi erano asciutti. Suo padre le aveva insegnato a
non piangere. Lei aveva un padre vero, non un patrigno.
Si girò e se ne andò.
Artyom rimase chinato sopra la tazza di decotto di funghi,
bianca col bordo dorato sbeccato. Omero sedeva a fianco, in prudente silenzio. In cucina incominciarono a ritornare le persone. Parlavano del fatto che una muffa bianca avesse colpito i funghi, sospiravano al pensiero di una nuova guerra, spettegolavano su quale marito avesse palpeggiato quale donna alla fattoria dei maiali. Passò di corsa un porcellino rosa strepitante seguito da una pallida bambina tisica, un gatto con la coda drittissima aggirò il tavolo, si strofinò contro il ginocchio di Artyom, lo fissò affamato. Il vapore sopra la tazza si raffreddò, il tè si coprì di schiuma. E dentro Artyom tutto iniziò a ricoprirsi di schiuma. Mollò la tazza, guardò in avanti. Lì c’era il vecchio.
“Ecco qual è la storia, nonnino”.
“Io… mi scusi”.
“Sei venuto inutilmente, eh? I posteri non saranno
contenti. Chi li avrà”.
“No, non inutilmente”.
Artyom lo zittì: che vecchio cocciuto!
Sollevò il suo sedere dalla panca, lo trascinò fuori dalla
cucina: la colazione era finita, ora bisognava espletare l’obbligo lavorativo. Omero gli si avvicinò da dietro.
“Mi perdoni… di cosa… di cosa parlava quella ragazza? Un’antenna… Radioamatore… Certo, non è affar mio, ma… Lei sale su? Ascolta la radio?”
“Salgo e ascolto”.
“Spera di trovare altri sopravvissuti?”
“Spero di trovare altri sopravvissuti”.
“E come procede?”
Nella sua voce Artyom non sentì alcuna presa in giro.
L’uomo era semplicemente curioso, come se Artyom si occupasse di una cosa assolutamente comune. Come se avesse portato all’Hansa dei prosciutti secchi.
“Non procede”.
Omero fece un cenno col capo, si rabbuiò. Stava per raccontargli qualcosa, ma poi cambiò idea. Voleva esprimergli il suo dispiacere oppure farlo ragionare? Si fingeva interessato? Ad Artyom non gliene fregava niente.
Arrivarono fino al recinto con le biciclette.
Artyom non amava i funghi perché li amava Anya, non gli piacevano i maiali per la puzza che lui era l’unico a sentire. E si era messo d’accordo: era stato esonerato da quel lavoro in quanto eroe, ma alla VDNKh non davano da mangiare ai parassiti. Se avevi finito il tuo turno al posto di blocco nel tunnel, lavoravi alla stazione. Artyom aveva scelto le biciclette.
Erano quattordici, allineate, col manubrio rivolto verso il muro, al quale erano appesi dei manifesti. Su uno c’erano il Cremlino e la Moscova, su un altro una bellezza appassita in costume rosa, sul terzo i grattacieli di New York, sul quarto un monastero innevato e le feste ortodosse su un calendario a caselle. Segui il tuo stato d’animo e gira i pedali. Le biciclette erano poste su alcune traverse, dalle ruote le cinghie andavano verso la dinamo. A ogni bicicletta era fissato un fanalino che illuminava debolmente il tuo manifesto da sogno. L’elettricità restante andava agli accumulatori per alimentare la stazione.
Le biciclette si trovavano nel tunnel meridionale crollato, i forestieri non vi avevano accesso: erano un obiettivo strategico. Il vecchio non era ancora passato da lì.
“È con me”, disse Artyom alla guardia senza un perché, e Omero fu ammesso.
Artyom salì in sella al telaio arrugginito, strinse il manubrio di gomma. Lì davanti si stagliava il poster di Berlino che si erano procurati grazie ai commercianti di libri dell’Hansa: la porta di Brandeburgo, la torre della televisione e la statua nera della donna con le mani sollevate. Artyom aveva capito che questa porta assomigliava molto all’ingresso della VDNKh, mentre la torre della televisione berlinese, anche se aveva nel mezzo una specie di escrescenza o di bolla sferica, ricordava la torre di Ostankino. E quella statua di donna, che non si capiva bene se urlasse o si stringesse le orecchie… Gli sembrava di non andare da nessuna parte.
“Non vuoi pedalare un po’, nonno?”, Artyom si rivolse a Omero. “Fa bene al cuore. Camperai più a lungo qui”.
Ma il vecchio non rispondeva, guardava con sguardo vitreo le ruote sgonfie che giravano e cercava di aggrapparsi all’aria. Il suo viso era storto come quello di un paralitico: una metà sorrideva, l’altra era atrofizzata.
“Stai bene, nonnino?”, chiese Artyom.
“Sì. Mi sono ricordato di qualcosa, di qualcuno”, Omero emise un suono roco, si schiarì la gola e si riprese.
“Già”.
Tutti avevano delle persone da ricordare. Trecento ombre a persona. Non aspettavano altro. Disponevano i loro calappi, sistemavano i tiranti, tendevano i boschetti, i fili della ragnatela – e aspettavano. A qualcuno la bicicletta senza ruote ricordava di aver insegnato ai figli a pedalare nel cortile, a qualcun altro il fischio del bollitore riportava alla memoria la cucina dei genitori, quando nei giorni di festa andava da loro per pranzare e confidarsi. Strizzavi gli occhi e in quello stesso istante tra un presente e l’altro gli occhi scorgevano improvvisamente il passato e i loro volti. Con gli anni, a dire il vero, vedevano sempre peggio. Pazienza.
“Come hai fatto a sapere di me?”
“La sua fama”, sorrise Omero. “Tutti la conoscono”. Artyom fece una smorfia. “La fama”, pronunciò quella
parola come se volesse sputarla.
“Lei ha salvato la metropolitana, le persone. Se non avesse
eliminato coi missili quelle carogne… A essere onesto, io non capisco. Perché non vuole raccontare questa storia?”
Lo aspettavano la torre della televisione, l’ingresso della VDNKh, la donna nera con le braccia sollevate. Bisognava montare su un’altra bicicletta, ma tutte le altre erano già occupate e ad Artyom era toccata proprio quella. Avrebbe voluto girare i pedali nella direzione opposta, indietro, lontano dalla torre, ma così l’elettricità non veniva prodotta.
“Ho sentito parlare di lei da Melnik”.
“Cosa?”
“Melnik. Lo conosce? Il comandante dell’Ordine. Lei ovviamente è informato sull’Ordine… Gli spartani… Anche lei, da quanto ho capito, ne faceva parte, prima…”
“È stato Melnik a mandarti da me?”
“No. Melnik mi ha semplicemente raccontato quello che lei ha riferito. Dei Tetri. Di come ha percorso tutta la metropolitana… E poi ho iniziato a ricercare da solo, per quanto potevo. Comunque ci sono molte cose non chiare. Ho capito che senza di lei non ne sarei mai venuto a capo e ho deciso…”
“Ha detto qualcos’altro?”
“Chi?”
“Melnik, ha detto qualcos’altro di me?”
“Sì”.
Artyom smise di girare i pedali. Scavalcò il telaio e balzò
sul pavimento. Incrociò le braccia sul petto. “Cosa?”
“Che si è sposato e ha iniziato a condurre una normale vita umana”.
“Ha detto così”.
“Proprio così”.
“Una normale vita umana”, Artyom sorrise.
“Se non mi confondo”.
“Non ha precisato che ho sposato sua figlia?”
Omero scosse la testa.
“È tutto?”
Il vecchio masticò. Sospirò. Confessò. “Ha detto che lei ha
avuto delle turbe mentali”.
“Certo, io ho avuto delle turbe mentali”.
“Io mi limito a riferire quello che ho sentito…” “Nient’altro?”
“Non mi sembra”.
“Per esempio, che mi vuole ammazzare? Per colpa della
figlia… oppure…”
“No, niente di simile!”
“Oppure che mi aspetta di ritorno… nella formazione?” “Non ricordo…”
Rimase in silenzio a digerire le informazioni. Si ricordò che Omero era ancora lì e lo stava studiando.
“Turbe mentali…”, Artyom sghignazzò come poteva.
“Io non lo penso”, lo avvertì Omero. “Qualunque cosa dicano, io sono assolutamente convinto del fatto che…”
“Come fai a saperlo? Come fai?”
“La considerano pazzo solo perché continua a cercare dei sopravvissuti? Solo perché non vuole arrendersi? Ascolti”, il vecchio guardava Artyom con aria seria. “Lei si sta rovinando per gli altri e io non capisco francamente perché loro si comportino così nei suoi confronti”.
“Ci vado ogni santo giorno”.
“Di sopra?”
“Ogni giorno salgo in superficie con la scala mobile. Poi vado
fino a quel grattacielo. Salgo a piedi per la scala fino al tetto. Con lo zaino”.
Quelli sulle bici vicine si misero ad ascoltarlo e rallentarono la loro pedalata.
“Ebbene sì! Non ho mai sentito una risposta! E allora? Cosa vuol dire?!”, Artyom non si rivolgeva più a Omero, ma a tutti quei maledetti ciclisti che correvano verso il muro, verso la Terra. “Questo non vuol dir niente! Come fate a non sentirlo? Devono esserci degli altri uomini! Devono esserci altre città! Non possiamo essere gli unici in questo buco, in queste grotte!”
“Sei furbo tu, Artyom! Ci hai rotto ormai!”, un ragazzo col naso lungo e gli occhietti piccoli non riuscì più a trattenersi. “Gli americani hanno bombardato tutti! Non c’è niente! Cosa continui a tormentarti?! Loro hanno ammazzato noi, noi loro, punto e basta!”
“E se non fossimo gli unici?”, domandò Omero quasi rivolto a se stesso. “Se vi dicessi che…”
“Sale lassù come se andasse a lavorare! Si becca le radiazioni e le passa agli altri! Un cadavere ambulante!”, il ragazzo non riusciva a fermarsi. “Adesso ci contaminerà tutti?!”
“Se vi dicessi che ci sono dei sopravvissuti? Se vi dicessi che ci sono stati segnali provenienti da altre città, e che sono stati intercettati?”
“Ripeti”.
“Ci sono stati segnali da altre città”, disse con fermezza Artyom. “Li hanno colti. Hanno parlato”.
“Balle”.
“Conosco la persona che ha avuto lo scambio via radio…” “Balle”.
“E se ora costui fosse davanti a voi? Cosa direste, allora?”,
Omero strizzò l’occhio ad Artyom. “Allora?”
“Che sei impazzito, nonno. O dici balle. Sono balle, vero? Eh?”
FINE DEL SECONDO CAPITOLO